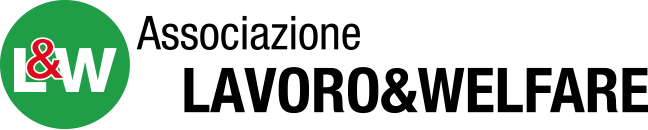(e)labora · Summer School 2016

di Giampiero gramaglia
Le incognite di un negoziato di secessione non ancora iniziato
Perché il calcio d’inizio della partita della trattativa lo deve dare il governo di Londra, facendo scattare il negoziato di secessione previsto dall’articolo 50 del Trattato. E questo non avverrà presto, probabilmente non prima della fine dell’anno, perché la Gran Bretagna non ha fretta (mentre ne hanno, o almeno ne dichiarano i suoi partner). C’è l’impressione che la May e i suoi ministri vogliano sapere come andrà a finire la partita, prima di scendere in campo.
Butta male per i cittadini britannici – e siamo nella serie ‘chi è causa del suo mal pianga se stesso’ -, ma anche per tutti noi cittadini europei. Perché la secessione britannica arriva nel momento più fragile dell’integrazione europea: l’Unione non è neppure saldamente fuori dalla crisi economica e finanziaria che l’ha azzannata nel 2008, anzi sta rallentando la sua crescita (e l’Italia è il ‘frenatore in capo’).
La gente avverte il rischio di una battuta d’arresto, invece che di una accelerazione, della crescita. E percepisce una minaccia, per quanto irrazionale essa possa essere, dall’ondata di migrazione che non è più emergenza, ma costante; e, aizzata dalla propaganda populista, collega con paura il flusso alla minaccia terroristica dell’integralismo islamico. Che non può essere sottovalutata.
Dopo la botta della Brexit, c’è il rischio che la costruzione si sfaldi. La Brexit offre una tentazione ai francesi che votano Le Pen, agli italiani che votano Salvini – e pure per una buona fetta di quelli che votano Cinque Stelle -, ai tedeschi che votano Alternativa per la Germania, agli xenofobi belgi e agli anti-Islam olandesi: tutti Paesi fondatori, tutti Paesi di quello che una volta era il nocciolo duro dell’integrazione europea.
Tenta meno, la Brexit, i Paesi come la Polonia o la Rep. Ceca, che pure hanno governi euro-scettici, ma che, dall’appartenenza all’Ue, ricavano un flusso annuo di denaro prezioso per le loro economie, mentre i Paesi fondatori sono tutti contribuenti netti.
Non è l’ora di compromessi al ribasso
Negoziati con la Gran Bretagna nel segno di compromessi al ribasso, che sfocerebbero in una sorta di Europa ‘à la carte’, dove ciascuno fa solo quel che gli piace: è davvero lo scenario peggiore che si possa immaginare, un cocktail di procedure e grettezze che metterebbe a dura prova il più europeista dei cittadini.
Altro che compromessi al ribasso. L’obiettivo deve essere il rilancio dell’Unione politica spingendo verso un’Europa dotata di una difesa comune, di un’economia più giusta e di una polizia federale.
Le organizzazioni federaliste e i guru dell’integrazione offrono ricette per rispondere alla Brexit rilanciando, invece che frenando, il processo, non limitandosi a cercare di arginare la disgregazione. Fra le proposte, un fondo europeo contro la disoccupazione e un Ministero delle Finanze europeo, sovranazionale, che attui politiche di sviluppo e prosegua il cammino dell’Unione sognato e tracciato dai Padri Fondatori e abbandonato dai loro emuli.
Bisogna mostrare ai cittadini che l’Unione è per loro un’opportunità, subito sui fronti dell’economia e dell’immigrazione, i più urgenti, dove ci sono bisogni concreti e timori viscerali. Ma, finora, l’Ue, le sue istituzioni, i suoi leader non sono stati né coraggiosi né determinati. A parole, prospettano nuovi modelli, ma di fatto restano impaniati nelle procedure e ostaggio delle paturnie britanniche.
Del resto, quelle che non mancano, all’Unione europea, sono le emergenze: quando non sai come affrontarne una, ne esplode un’altra che ti fa accantonare la prima per contrastare l’ultima. Che resta, irrisolta, in testa alla lista delle priorità, fin che un’altra non la caccia. Una girandola tragica, che genera sfiducia e che autorizza la paura.
Le teste che non cadranno
Pareva che la Brexit dovesse essere un’ecatombe, teste tagliate, poteri perduti. Invece, sono rimasti tutti al loro posto e, probabilmente, continueranno a restarvi. ‘Ercolini sempreinpiedi’ dell’Unione? Manco tanto, perché a buttarli giù nessuno ci ha davvero provato. Fra i pezzi da novanta dell’Ue, finora la Brexit ha fatto un’unica vittima: il commissario europeo Jonathan Hill, già responsabile dei Servizi finanziari nell’Esecutivo comunitario, dimessosi ‘sponte sua’. Al suo posto, fin quando almeno il Regno Unito non sarà proprio fuori dall’Ue – e la Commissione Juncker sarà intanto giunta a fine mandato -, ecco sir Julian King, sorta di commissario dimezzato.
Il sì nel referendum ha invece riportato in primo piano sullo scacchiere europeo Michel Barnier, ex ministro degli Esteri francese ed ex uomo forte al Mercato interno nella Commissione Barroso, nominato capo negoziatore per l’esecutivo comunitario.
A innescare l’ipotesi di sommovimenti nelle istituzioni europee era stata la stampa tedesca: la Faz e poi Die Welt avevano giudicato “inadeguato” il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, che pure era stato voluto a quel posto in primis dalla cancelliera Merkel. E siccome, a fine anno, ci sarà da rinnovare il mandato del presidente del Consiglio europeo, il polacco Donald Tusk, che non è in sintonia col suo governo, e neppure coi Grandi dell’Unione, e del Parlamento europeo, dove il tedesco Martin Schulz giunge al termine del suo secondo mandato, erano subito partite voci d’ogni genere: fra le più accreditate, una prevedeva Schulz al posto di Juncker – e del resto Schulz era il candidato socialista a quel posto, nel 2014.
Il ‘valzer delle poltrone’ non è neppure durato il tempo di un’estate bruxellese, che spesso coincide con una settimana di luglio: la Brexit non ha sconquassato gli organigrammi istituzionali; e neppure i calendari, tranne che la Gran Bretagna esce dalla rotazione delle presidenze di turno del Consiglio dell’Unione – funzione che doveva assumere il 1° luglio 2017, quando il negoziato per l’uscita sarà stato almeno avviato. Il vuoto sarà riempito dal Belgio, Paese di sicura militanza ed esperienza europee, che non suscita né gelosie né sospetti e i cui costi d’esercizio si riducono al minimo: Bruxelles ha avuto la presidenza di turno semestrale per l’ultima volta nel 2010, quando seppe condurla senza inconvenienti nonostante il governo gestisse solo gli affari correnti, nella più lunga crisi politica di una democrazia occidentale dei tempi moderni, ben 535 giorni.
Giampiero gramaglia
è giornalista e consigliere dell'Istituto Affari Internazionali